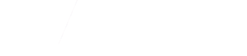Dieci stanze, dieci artisti, dieci sopravvivenze possibili
Nel suo libro Davide Uria ci conduce con lucidità e ironia attraverso le sale silenziose dell’arte contemporanea, che diventano metafora delle nostre relazioni, dei nostri limiti e della nostra capacità – sempre più rara – di tollerare il mistero.
Il museo come corpo vivo
Ci sono luoghi che ci mettono alla prova, e non sono i deserti, i tribunali o i confessionali. Sono i musei d’arte contemporanea. In questi spazi, ogni cosa sembra eludere la logica: un tubo al neon può essere arte, ma non lo è la lanterna della nonna. Un sacchetto di plastica lasciato a terra è opera, ma non lo è il caos della nostra camera da letto.
Davide Uria, con un’osservazione acuta e disarmata, non cerca di sciogliere questo paradosso, ma di starci dentro. Il suo Sopravvivere a un museo d’arte contemporanea non è solo una guida ironica all’interpretazione delle opere: è una dichiarazione di poetica. Un invito a riconoscere che la difficoltà di comprendere un’opera è specchio della nostra difficoltà di comprendere la vita. E allora forse, come suggeriva Maurice Merleau-Ponty, “la percezione non è un atto, ma un campo”. Non si tratta di dominare il significato, ma di lasciarsi attraversare.
Ecco allora il sottotitolo: “Dieci stanze, dieci artisti, dieci sopravvivenze possibili.”
Non è solo una struttura narrativa. È un progetto di resistenza esistenziale. Ogni stanza rappresenta un ambiente diverso – fisico ma anche psicologico – dove il lettore viene condotto ad affrontare un artista e una parte di sé. Come in un percorso museale (o terapeutico), ci si scontra con la bellezza, l’assurdo, il silenzio, la provocazione, la vertigine del senso, e in ciascuna di queste dieci tappe si apprende un modo per sopravvivere: all’opera, ma anche a se stessi.
Il fallimento come forma di sapere
Il libro di Uria si legge come un saggio mascherato da diario, o forse come un diario mascherato da saggio. L’autore parte dalla fragilità dell’esperienza individuale: non capisco l’arte contemporanea, non so se sono io il problema. Ma questa ammissione, che potrebbe sembrare una resa, è in realtà una presa di posizione radicale. Come scrive Roland Barthes: “ciò che mi tocca non è ciò che capisco, ma ciò che resiste”. E allora la mancanza di comprensione diventa terreno fertile per la riflessione, per l’ascolto, per la trasformazione.
Viviamo in un’epoca ossessionata dalla prestazione cognitiva: comprendere, etichettare, riassumere. Ma Uria ci ricorda che alcune esperienze – come l’amore, la morte, l’arte – non si possono spiegare, solo attraversare. E che forse il compito più alto dell’arte non è insegnarci qualcosa, ma renderci consapevoli della nostra opacità.
Relazioni: l’opera più difficile da decifrare
Una delle intuizioni più forti del libro è che le opere d’arte contemporanea somigliano agli esseri umani. Sfuggono, disattendono, si mostrano e poi si sottraggono. Le relazioni sono piene di punti ciechi, fraintendimenti, simboli mal interpretati. Eppure, come per un’opera astratta, spesso restiamo lì, a osservare, a tentare, a cercare un contatto. Perché sentiamo che qualcosa ci chiama, anche se non sappiamo cosa.
Susan Sontag, nel suo celebre Contro l’interpretazione, scriveva: “Oggi è necessario recuperare i nostri sensi. Dobbiamo imparare a vedere di più, a sentire di più”. Non tutto va decodificato, dissezionato, spiegato. Uria sembra fare propria questa lezione: l’opera – come l’altro – non è lì per essere capita, ma per essere abitata. Ed è in questa coabitazione, in questa tensione tra distanza e intimità, che si gioca la possibilità di un incontro autentico.
Sopravvivere come atto poetico
Il verbo “sopravvivere” nel titolo non è scelto a caso. Non si tratta di godersi l’arte, o la vita. Si tratta di sopravvivere ad essa, con tutto ciò che comporta: la confusione, il disincanto, la fatica di esserci anche quando non c’è nulla di chiaro. Come in un museo, anche nella vita spesso entriamo in una stanza senza sapere cosa ci aspetta. E se ci aspetta qualcosa. Uria ci invita a restare, a non uscire subito. A non avere paura del vuoto.
Come scrive Nicolas Bourriaud, teorico dell’estetica relazionale: “L’arte contemporanea è la creazione di spazi d’incontro. Non mostra oggetti, ma propone forme di convivenza”. E forse proprio questo è il senso più profondo del libro: creare uno spazio conviviale con la nostra incertezza, con la nostra incapacità di spiegare tutto. Trovare una casa nel dubbio.
Un elogio dell’imperfezione
Davide Uria scrive con uno sguardo laterale, che si nutre di stupore e pudore. Non finge di sapere, ma si fa guida nel non sapere. Il suo sguardo è quello di chi ha visto relazioni sgretolarsi per un gesto mancato, di chi ha attraversato giornate vuote come tele bianche, di chi si è chiesto – senza risposta – perché qualcosa (o qualcuno) ci abbia toccati così a fondo. E proprio per questo, Sopravvivere a un museo d’arte contemporanea è un libro che parla di arte solo per parlare meglio della vita.
Un invito a disimparare la fretta, a tollerare lo spaesamento, a lasciare che un’opera ci ferisca senza immediatamente chiuderci la ferita con una spiegazione.
Perché, come scriveva Emily Dickinson:
“Dove non capisco, c’è la verità che mi sfugge. E quindi insisto.”