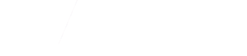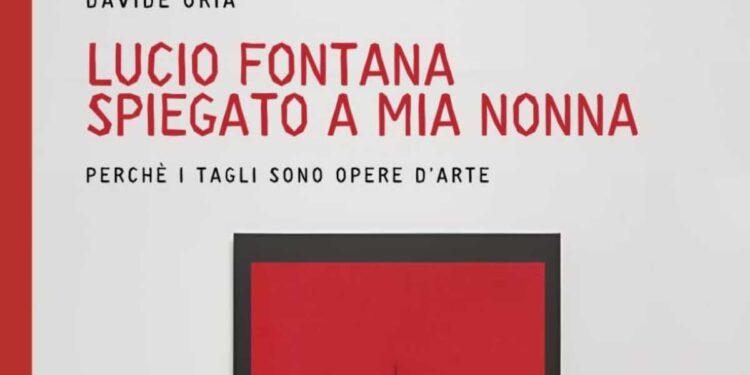L’arte contemporanea, si sa, non è facile. Non parla sempre un linguaggio immediato, non si lascia spiegare con formule semplici, spesso provoca più smarrimento che entusiasmo. Eppure, può succedere che proprio in mezzo a un museo pieno di installazioni incomprensibili, o davanti a una tela tagliata in due, ci si senta vivi. È da questa tensione – tra spaesamento e fascino – che nascono i due libri di Davide Uria: Lucio Fontana spiegato a mia nonna: Perché i tagli sono opere d’arte e Sopravvivere a un museo d’arte contemporanea: Dieci stanze, dieci artisti, dieci sopravvivenze possibili. Due titoli ironici, certo, ma anche estremamente seri, se si guarda sotto la superficie.
Nel primo volume, Uria prende per mano il lettore e lo porta a conoscere uno degli artisti più emblematici del Novecento: Lucio Fontana. Ma non lo fa con il tono accademico di chi sa e vuole insegnare. Lo fa parlando a una nonna – simbolo di quel pubblico che guarda un’opera contemporanea e chiede candidamente: “Ma questo è davvero arte?”. È proprio da lì che parte il dialogo. Perché il taglio di Fontana non è uno sfregio, ma un gesto filosofico, un’apertura verso lo spazio reale. È la negazione della pittura come finestra e l’inizio di un’arte che dialoga con il vuoto, con la luce, con il pensiero. Uria riesce a raccontare tutto questo con uno stile che unisce la chiarezza alla profondità, senza rinunciare a una buona dose di ironia.
Ma se il primo libro è in qualche modo una monografia atipica, il secondo si presenta come un vero e proprio percorso narrativo. Sopravvivere a un museo d’arte contemporanea è una sorta di guida esistenziale. Dieci stanze, dieci artisti, dieci modi per affrontare le difficoltà – spesso psicologiche – che si provano dentro un museo. Chi non si è mai sentito a disagio davanti a un’opera troppo concettuale? Chi non ha mai pensato, almeno una volta, di non essere “all’altezza”? Uria ribalta questa percezione: non sei tu a non capire, è l’arte che ti invita a cambiare prospettiva. Attraverso riferimenti filosofici, ma anche con un linguaggio narrativo, l’autore suggerisce che il museo non è un tempio da temere, ma un campo di prova per la mente e per il cuore.
I due libri, letti insieme, formano un dittico coerente. Da un lato la spiegazione simbolica di un gesto rivoluzionario, dall’altro la preparazione mentale a un’esperienza immersiva. Il centro resta sempre lo stesso: rendere l’arte contemporanea accessibile, senza svilirla. Con leggerezza, sì, ma anche con metodo. E questo è forse il punto più interessante del lavoro di Uria: la sua è una divulgazione colta, fondata su studi e letture, ma mai ostentata. Un sapere che si offre con naturalezza, senza pedanteria.
Nel panorama editoriale italiano, dove spesso l’arte contemporanea è spiegata con toni aulici o, al contrario, ridotta a puro intrattenimento, Davide Uria ci presenta una terza via: quella dell’ironia consapevole, che non semplifica ma accompagna. Un’arte dello spiegare che parte dal basso, da una domanda ingenua, per arrivare a riflessioni filosofiche che interrogano il senso stesso del guardare, del creare, del comprendere.
Se siete curiosi, se vi siete sentiti fuori posto in un museo, se avete mai pensato che l’arte contemporanea fosse “una presa in giro”, questi due libri potrebbero cambiare il vostro punto di vista. Non offrono risposte definitive, ma lasciano aperte molte porte. Proprio come i tagli di Fontana.